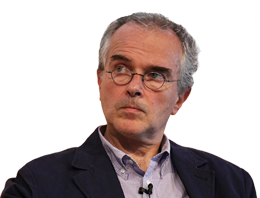In poche settimane, il cancelliere in pectore Friedrich Merz ha imposto una svolta alla Germania, modificando la Costituzione e permettendo nuovo debito per investire in difesa e in infrastrutture.
La scelta è stata salutata positivamente. La Germania sta assumendo responsabilità politiche ed economiche che per decenni aveva evitato. La nuova America di Donald Trump è riuscita a scuotere l’establishment tedesco dal suo dormiveglia.
C’era e c’è la sensazione che senza la Germania una nuova sovranità europea anche in campo militare fosse e sia impossibile.
Eppure, il riarmo della Germania – perché di questo in fondo si tratta – non può avvenire a bocce ferme, per così dire.
Al centro del continente, il paese è sempre stato oggetto di un drammatico dilemma. Storicamente, la Germania è stata o troppo debole (come nel Seicento e nel Settecento) o troppo forte (come alla fine dell’Ottocento e all’inizio del Novecento). Le altre potenze si sono coalizzate contro di essa o ne sono state dominate.
Per certi versi la Storia europea dimostra come la stabilità del continente sia funzione soprattutto della forza della Germania.

Dalla fine della Seconda guerra e poi successivamente dopo la Caduta del Muro di Berlino la straordinaria energia del paese è stata convogliata dalla doppia presenza del progetto europeo e dell’alleanza americana. La Germania ha affidato la propria sicurezza agli Stati Uniti, incanalando la sua forza economica prima nel mercato comune e poi nella moneta unica.
Il riarmo tedesco ha già provocato i primi dubbi sul fronte finanziario. Il prossimo indebitamento della Germania ha scatenato uno straordinario aumento dei rendimenti obbligazionari, soprattutto nei paesi più indebitati, come la Francia e l’Italia.
L’impatto potrebbe rivelarsi notevole, perché potrebbe tradursi non solo in un aumento dei costi di servizio del debito pubblico, ma anche in tensioni sui mercati obbligazionari e tra i governi nazionali, tensioni non dissimili da quelle scatenate dalla crisi debitoria di un decennio fa.
Dubbi poi potrebbero emergere anche sul fronte politico. Il progetto europeo è poggiato per 70 anni su delicati equilibri, anche militari. L’ombrello americano non ha consentito solo ai paesi europei di concentrare la spesa pubblica su welfare e previdenza. Ha anche avuto un ruolo nel compensare agli occhi dei tedeschi la force de frappe francese.
In questo senso, il disimpegno americano e il riarmo tedesco impongono alla coppia franco-tedesca di trovare una nuova armonia, un nuovo ambito in cui possano essere arginate le eventuali spinte centrifughe e nazionaliste.
Jean Monnet (1888-1979) credeva fermamente che per evitare nuovi conflitti in Europa fosse necessario mettere in comune la gestione dell’acciaio e del carbone, le due materie prime che nei secoli avevano contribuito a numerose guerre sul continente. Nel 1952 nacque così la CECA.
L’uomo politico francese aveva ragione, e da allora il progetto comunitario ha fatto passi da gigante, successivamente con la nascita della CEE e poi dell’Unione europea. Oggi la stessa comunità d’intenti, la stessa condivisione degli strumenti e dei poteri appaiono urgenti, per evitare tensioni finanziarie, per sfogare pressioni nazionaliste, per prevenire corse al riarmo e squilibri pericolosi. Il ragionamento di Jean Monnet rimane straordinariamente attuale.